Ci sono emozioni che spaventano per la loro intensità, e che per questo tendiamo a reprimere, nascondere, o peggio, a travestire. La rabbia è certamente tra queste. Non è mai elegante, non è socialmente gradevole, non è facilmente addomesticabile. Ma è, tra tutte, forse l’emozione più autentica, più capace di segnalare che qualcosa non va. La questione, allora, non è come eliminarla, ma come ascoltarla. E soprattutto: come distinguere tra una rabbia che costruisce e una che distrugge.
La rabbia costruttiva ha una dignità silenziosa.
Non ha bisogno di esplodere per esistere. È quella che si manifesta nel momento in cui ci rendiamo conto che qualcosa ha superato una soglia per noi importante: un confine che è stato violato, un diritto che è stato ignorato, un bisogno che è stato trascurato. È una rabbia che non aggredisce, ma chiarisce. Non confonde, ma definisce. È la voce interiore che ci spinge a dire di no, a uscire da una dinamica nociva, a proteggerci da un legame che ci svuota o da un contesto che ci mortifica.
La rabbia distruttiva, al contrario, nasce dalla ferita non riconosciuta.
È la rabbia che non sa dove andare, e allora colpisce ovunque. Può manifestarsi in forma di aggressività passiva, sarcasmo, tensione costante, o scoppi violenti apparentemente sproporzionati. È spesso il prodotto di una lunga frustrazione accumulata, di bisogni cronicamente ignorati, di emozioni compresse per troppo tempo. E quando esplode, non distingue: si accanisce contro il partner, il figlio, l’amica, lo sconosciuto in macchina. O contro sé stessi, in forme più sottili, ma non meno laceranti.
La differenza tra le due sta tutta nella consapevolezza.
La rabbia costruttiva sa da dove viene e dove vuole andare. Ha una direzione, un’intenzione trasformativa. Può ferire, sì, ma solo per chiarire un malinteso o ristabilire un equilibrio. Non lascia scorie, né imbarazzo. Dopo, si respira meglio. La rabbia distruttiva, invece, genera senso di colpa, rotture, confusione. Brucia tutto, ma non illumina.
Per distinguere le due forme, occorre una competenza emotiva raffinata: non basta “sfogarsi”, né tenere tutto dentro. Serve un lavoro paziente e profondo su di sé. Serve imparare ad ascoltare il proprio corpo – perché la rabbia ha sempre una manifestazione fisica, spesso anticipata dal battito che accelera, dalle mani che stringono, dalla mandibola che si contrae. Serve darsi il permesso di nominare ciò che si prova, anche quando non è socialmente accettabile. E soprattutto, serve imparare a dare alla rabbia uno spazio, un linguaggio e una direzione.
Alcuni segnali che possono guidarci in questa distinzione:
-
La rabbia costruttiva è collegata al presente. La distruttiva, spesso, si alimenta di ferite antiche.
-
La rabbia costruttiva chiede giustizia. La distruttiva cerca punizione.
-
Dopo la rabbia costruttiva, si prova chiarezza. Dopo quella distruttiva, si prova svuotamento o vergogna.
-
La rabbia costruttiva può convivere con la tristezza o la delusione. La distruttiva, spesso, le soffoca.
In molte esperienze di crescita personale – anche in percorsi psicologici mirati – ci si accorge che imparare a usare la rabbia in modo costruttivo è una delle conquiste più potenti. Non significa diventare “irascibili” o “incontrollati”, ma al contrario: significa riconoscere la rabbia come una bussola. Come una fonte di energia che può servire a proteggerci, a smettere di compiacere, a uscire da ruoli che non ci appartengono più. È un’emozione che, se accolta con intelligenza, ci guida verso la coerenza.
Ci sono donne che hanno imparato a usare la loro rabbia per lasciare una relazione tossica, per ridefinire la propria posizione nel lavoro, per difendere il proprio tempo, il proprio corpo, la propria verità. Non urlando. Non esplodendo. Ma restando. Smettendo di giustificarsi. Smettendo di chiedere il permesso per essere sé stesse.
Imparare a distinguere tra rabbia che ci difende e rabbia che ci sabota è una delle forme più raffinate di intelligenza emotiva. E può cambiare profondamente la qualità delle nostre relazioni, e della nostra vita interiore.
-
Averill, J. R. (1982). Anger and Aggression: An Essay on Emotion. Springer-Verlag.
-
Linehan, M. M. (1993). Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. Guilford Press.
-
Greenberg, L. S., & Paivio, S. C. (1997). Working with Emotions in Psychotherapy. Guilford Press.
-
Tavris, C. (1989). Anger: The Misunderstood Emotion. Simon & Schuster.
-
Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst. Penguin Press.
-
Fernandez, E., & Kerns, R. D. (2008). Treating Anger Disorders: A Cognitive-Behavioral Approach. New Harbinger Publications.
-
Izard, C. E. (1991). The Psychology of Emotions. Plenum Press.
-
Potegal, M., Stemmler, G., & Spielberger, C. (2010). International Handbook of Anger. Springer.
-
American Psychological Association. (2023). Anger management strategies. www.apa.org
-
Todd, C. (2025). Constructive and Destructive Anger: Understanding the Difference. Psychology Today.
![]() La consapevolezza è il vero lusso che ci cambia la vita!
La consapevolezza è il vero lusso che ci cambia la vita!
Dr. Elena De Franceschi - Psicologa clinica - e.defranceschi@psicoaosta.com - info@psicoaosta.com -



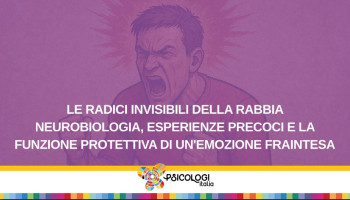


commenta questa pubblicazione
Sii il primo a commentare questo articolo...
Clicca qui per inserire un commento