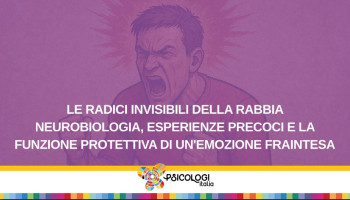Con l’espressione “maltrattamento infantile” ci si riferisce a <<pratiche di accudimento aberranti […] e inaccettabili per la maggioranza della popolazione in una data cultura e in un particolare periodo storico>> (Ammaniti, 2001, pp. 120-121).
Il maltrattamento può prendere la forma di trascuratezza, abuso fisico e sessuale e spesso viene perpetrato all’interno dell’ambito familiare, cosicché ne siano coinvolti entrambi i genitori (è raro che uno dei due ignori tale realtà) (Ammaniti, 2001); nello specifico:
- Trascuratezza: il bambino è spesso oggetto di carenze e omissioni rispetto ai suoi bisogni fisici e psichici; la grave trascuratezza può riguardare la sfera igienico-sanitaria o alimentare (non infrequenti i casi di denutrizione e conseguente difficoltà di accrescimento infantile)
- Abuso fisico: condizione in cui il figlio è oggetto di aggressioni fisiche, talvolta letali; i segni esterni comprendono lividi (localizzati o diffusi), escoriazioni, bruciature, fratture, lesioni, ecchimosi, ematomi subdurali, convulsioni, emorragie e coma
- Abuso sessuale: il genitore mette in atto comportamenti seduttivi e sessuali iperstimolanti con il figlio che, nei casi più gravi, è coinvolto dai genitori in atti sessuali masochistici (Ammaniti, 2001).
Nei bambini con un’età inferiore all’anno, la violenza rappresenta la principale causa di morte e, in quelli più grandi, un fattore predittivo di futuri comportamenti simili a quelli subìti (Ammaniti, 2001).
Tanto più il bambino è piccolo, tanto maggiore sarà l’impatto di una grave trascuratezza e/o di un abuso: Lyons-Ruth (1987) ha sottolineato infatti come un bambino al di sotto dei tre anni si debba trovare a lottare per la vita, giacché il suo stato biologico è sicuramente fragile.
Secondo quanto stabilito da varie ricerche di epoche diverse (Egeland, 1979; Malone, 2010) fattori correlati con il maltrattamento infantile sono la numerosità della famiglia, lo scarso distanziamento delle nascite, un atteggiamento negativo da parte della madre nei confronti della gravidanza, lo scarso supporto sociale e le basse condizioni socio-economiche.
Coloro che hanno studiato la relazione tra attaccamento e abuso (Lyons-Ruth et al., 1987) hanno riscontrato che, con maggior probabilità (82%), bambini maltrattati presentano un pattern d’attaccamento insicuro nei riguardi del genitore colpevole di violenza.
Forma particolare di maltrattamento che merita un discorso a parte è quella delle mutilazioni genitali femminili (MGF). Tale fenomeno riguarda un maltrattamento attuato su bambine di età compresa tra i 4 e gli 8 anni in nome dell’osservanza di pratiche tradizionali e messo in atto non solo nel Paese d’origine degli adulti, ma anche nei nuovi contesti (Bal Filoramo, 2004).
Le mutilazioni genitali femminili, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2004) riguarderebbero 135 milioni di bambine, alle quali ogni anno se ne aggiungerebbero 2 milioni; queste usanze consistono nella rimozione parziale o totale dei genitali esterni (nel caso dell’infibulazione, le grandi labbra vengono cucite lasciando solo una piccola apertura per la fuoriuscita dell’urina e del sangue mestruale; sarà necessario un taglio prima del rapporto sessuale col marito e del parto, ma, successivamente, la donna viene nuovamente infibulata), vengono praticate, alla presenza delle donne appartenenti al nucleo familiare, da un’anziana parente e/o levatrice che, senza anestesia, usa strumenti quali cocci di vetro, forbici e lamette spesso non adeguatamente sterilizzati e, quindi, causanti infezioni e dolori terribili (Bal Filoramo, 2004).
Secondo la tradizione, tali pratiche dovevano permettere alla piccola di acquisire un nuovo status sociale all’interno del gruppo di appartenenza e, quindi, costituivano un vero e proprio rito di iniziazione; oggi, essendo molto spesso venuto meno il significato originale, prevale l’aspetto crudele di pratiche che vengono attuate per volontà di coloro che dovrebbero tutelare la salute psico-fisica delle bambine e che dovrebbero assumere il ruolo di “base sicura”: i caregivers (Bal Filoramo, 2004).
Purtroppo, scarsissime si sono rivelate le ricerche in merito al legame tra tale pratica e l’attaccamento, ma dalle conseguenze descritte da Marica (2003), possiamo intuire che si tratti di uno stile ansioso/ambivalente se non addirittura disorganizzato: prima dell’evento, nelle ragazzine, che non possono certo confidarsi con i genitori, si riscontrano alti livelli di ansia e paura pre-evento, agitazione psicomotoria, turbe del carattere, mancanza di fiducia nei genitori verso i quali proveranno per sempre un forte sentimento di rabbia legato al senso di tradimento da loro subìto, insofferenza verso l’autorità, rifiuto della famiglia, sentimento d’impotenza e remissività, repressione delle emozioni, paura degli estranei, sogni simbolici ricorrenti che possono far pensare a un Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), effettivamente caratterizzato da un quadro sintomatologico che fa seguito a un episodio traumatico comportante la minaccia di morte o gravi lesioni e che si ripropone in incubi ricorrenti, angoscia nei momenti di ricordo, episodi dissociativi in cui viene riprodotto l’evento senza alcuna intenzionalità (Marica, 2003).
A tutto ciò, si deve aggiungere il fatto che essendo le MGF attuate anche nei nuovi contesti di vita, le bambine immigrate non le percepiscono come delle esperienze orribili, ma condivise dalle coetanee, bensì come una tortura che le allontana dalla maggioranza delle amiche, anche a causa del rigido mantenimento del segreto; infine, lo sviluppo sessuale sarà influenzato da tale esperienza voluta dai genitori: il rapporto con l’altro sesso, infatti, sarà gravato dal vissuto di diversità rispetto alle altre ragazze e da quello di vergogna (Bal Filoramo, 2004).
Bibliografia
- Ammaniti M. (a cura di) (2001), Manuale di psicopatologia dell’infanzia, Raffaello Cortina Editore
- Bal Filoramo L. (2004), Il danno psichico nei minori maltrattati, Hoepli
- Egeland B., Carlson E., Atkinson L., Goldberg S. (2004), Attachment issues in psychopathology and intervention, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers
- Lyons-Ruth K., Connell D., Zoll D., Stahl J. (1987), Infants at social risk: relations among infant maltreatment, maternal behavior and infant attachment behavior, in “Developmental Psychology”, n°2, pp.223-232
- Malone J., Levendosky A., Dayton C., Bogat G. (2010), Understanding the “ghosts in the nursery” of pregnant woman experiencing domestic violence: prenatal maternal representations and histories of childhood maltreatment, in “Infant Mental Health Journal”, n°21, pp.432-454
- Marica L. (2003) Mutilazioni genitali femminili, in “Link: rivista scientifica di psicologia”, n°2, pp.1-94