Ognuno di noi è una persona integra a livello superficiale, tuttavia è possibile manifestare delle frammentazioni interne.
Pensiamo a come siamo persone diverse sul lavoro, con gli amici o all’interno di una relazione intima o d’amore. Ogni contesto stimola l’agire e il sentire di una o più delle nostre parti. Esistono parti impaurite, arrabbiate, seduttive, invidiose, depresse ecc ecc. Ne esistono tantissime!
Le parti del sé sono un insieme di connessioni mentali caratterizzate da pattern coerenti di cognizioni, emozioni, percezioni, configurazione sensomotorie, comportamenti e stili relazionali. Ognuna ha bisogni, emozioni e paure specifiche!
Le parti sono tendenzialmente coese ma può succedere che, in seguito a varie esperienze, avvenga una separazione o una negazione di una o più di queste (Fisher, 2017). Per affrontare la propria vita infatti, ognuno di noi ha rinunciato a delle parti di sé che potevano sembrare pericolose (timore di abbandono, aggressione, violenza) e ha invece rinforzato quelle caratteristiche che venivano riconosciute positivamente.
Es: se da bambino ogni volta che mi arrabbiavo venivo punito, è possibile che impari a non dire quando sono arrabbiato, per evitare una punizione
Le strategie di difesa operate nel passato per affrontare una data situazione, portano alla formazione di quella che Janina Fisher chiama “parte apparentemente normale” che agisce e va avanti nelle proprie attività quotidiane progredendo nel proprio sviluppo evolutivo e una o più parti percepite “cattive”, quelle parti che non potevano essere mostrate e andavano tenute lontane. Questo può portare da adulti a vissuti di vergogna e insicurezza quando la parte “cattiva” irrompe in contesti quotidiani senza preavviso (Fisher, 2017; Meares, 2000).
La percezione può essere quella di “far finta”, di essere una frode. Si può sperimentare bassa autostima, angoscia, vergogna e disprezzo per sé stessi, vissuti di solitudine o problemi di impulsività. Può presentarsi inoltre molta fatica nell'identificare cosa scatena queste emozioni e pensieri (Fisher, 2017).
Disconoscere parti di sé e i propri bisogni può essere una strategia utile, soprattutto quando parliamo di trauma o situazioni pericolose. Può essere uno dei modi per poter continuare la propria vita “normale” e crescere o proprio sopravvivere. Questa strategia però, a lungo andare, ostacola l'accettazione di sé e influenza il modo in cui si sta in relazione col mondo e con gli altri (Fisher, 2017).
In terapia si impara a sviluppare interesse e compassione verso le diverse parti, cercando di connettersi empaticamente per comprenderne i bisogni. Cosa mi sta comunicando questa parte? Di cosa ha bisogno? Cosa la preoccupa? Cosa posso fare io, adulto, per prendermi cura di questo bisogno? (Fisher,2017).
Comprendere i bisogni e le emozioni che guidano le parti può permettere di:
- Sviluppare una maggiore consapevolezza e compassione per le proprie ferite
- Comprendere quali situazioni attivano le varie parti
- Sviluppare compassione e empatia verso le parti, comprenderle e prendersene cura (anche quelle che piacciono meno!)
- Rallentare le proprie risposte automatiche e concentrarsi su ciò che sta avvenendo: con quali lenti sto guardando la situazione? Quale parte di me si sente minacciata? Come posso tranquillizzarla?
Questo lavoro terapeutico può essere molto impegnativo ma permette di migliorare la relazione con sè e con gli altri. Il dialogo tra le parti stimola curiosità, empatia e aumenta la possibilità di poter diventare adulti interi e soddisfatti. È possibile prendersi cura dell' io ferito come si farebbe con un bambino per strada, con compassione e sincera preoccupazione; perché è quel bambino che ha permesso di essere qui ora, nel presente.
Integrazione non significa solo mettere insieme ma anche sviluppare un rapporto tra le parti, in modo che possano tutte sentirsi ascoltate e meritevoli di esistere.
Bibliografia
- Fisher J, Guarire la frammentazione del sé, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017.
- Meares, Intimità e alienazione, Cortina, Milano, 2005.

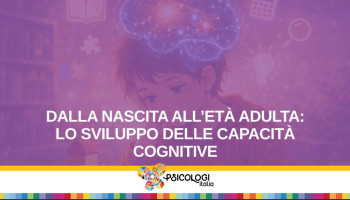

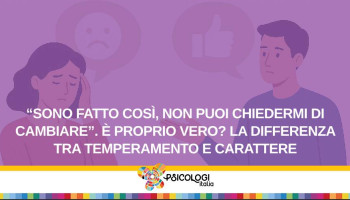
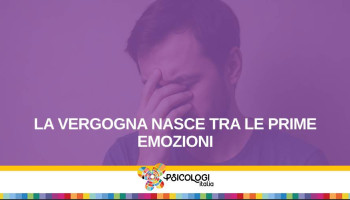

commenta questa pubblicazione
Sii il primo a commentare questo articolo...
Clicca qui per inserire un commento