Disturbi Specifici dell’Apprendimento: l’importanza dei Prerequisiti negli apprendimenti
Vorrei approfondire, con quest’articolo, l’importanza, anche in un’ottica di sostegno a chi soffre di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, dei Prerequisiti degli Apprendimenti, ossia, quell’insieme di competenze che costituiscono i mattoni necessari per la costruzione delle conoscenze e per l’acquisizione degli apprendimenti formali.
Riferendoci ad un’ottica di conoscenza dello sviluppo cognitivo di un bambino, sono riferibili agli aspetti attentivi, motori e motivazionali che lo accompagnano nel suo percorso di crescita. Ed in quest’ottica è utile considerare se e quanto un bambino abbia raggiunto una solida padronanza di tali prerequisiti, o se si debbano predisporre eventuali interventi mirati, qualora emergano fragilità in specifici ambiti.
I prerequisiti della letto-scrittura
La teoria di Cesare Cornoldi, relativa ai prerequisiti della letto-scrittura, ci dice che quando noi leggiamo non facciamo altro che tradurre un segno grafico in un suono. La scrittura, al contrario, è la traduzione di un suono in un segno grafico. Per questa ragione, per leggere e scrivere bene prima di tutto bisogna avere due grandi capacità, la capacità di analisi visiva, cioè si deve riuscire a percepire chiaramente il segno grafico ed a ricordarlo, e la capacità della discriminazione uditiva, cioè di riuscire a sentire i suoni e, soprattutto, a discriminarli bene.
Cercherò di chiarire i concetti.
1) Con i termini Analisi e Memoria visiva si vuole indicare la capacità di percepire in maniera esatta e stabile un segno grafico, di percepirne l'orientamento e soprattutto di ricordarselo. E’ importante sottolineare l’importanza dell’associazione stabile suono/segno grafico perché il problema dei bambini con DSA è proprio quello di non riuscire ad associare sempre in maniera stabile e giusta il suono al grafema: a volte ne associano uno, altre volte ne associano un altro perché hanno difficoltà a sentire o a percepire visivamente quel segno grafico. Nel nostro alfabeto ci sono alcune lettere - la p, la q, la b e la d - che hanno esattamente lo stesso segno grafico, solo che cambia l'orientamento. Questo significa che abbiamo bisogno di una capacità di analisi visiva, cioè di una capacità che permetta di discriminare bene l'orientamento di quel segno grafico. Se c’è una qualche difficoltà a livello visuo-percettivo alcune volte il segno sarà visto come una p, altre volte come una d, e quindi di volta in volta verrà espresso un suono diverso rispetto a quel segno grafico.
Siamo in presenza, in questo caso, di un DSA non verbale, in cui le difficoltà sono a carico dell'aspetto visuo-percettivo dell’analisi grafica, nell’analisi grafica. In questo caso naturalmente il lavoro di sostegno sarà basato sulla visuo percezione con l’utilizzo, magari, come strumento compensativo, della mascherina, del font ad alta leggibilità, del righello da mettere sotto la riga di lettura, offrendo una serie di strutture percettive che aiutano la corretta percezione del segno.
Da un punto di vista didattico, quindi, per questo bambino sarà molto importante iniziare a scrivere con lo stampato maiuscolo, perché lo stampato maiuscolo è una forma di scrittura percettivamente più semplice, è una scrittura bilineare che prevede solo due linee di demarcazione, quella di sotto e quella di sopra, e una sola banda spaziale che è quella dove si scrive.
Il corsivo a livello visivo percettivo è molto più complesso perché ci sono tre bande spaziali dove il bambino può scrivere: c'è la banda centrale, quella di sopra e quella di sotto.
E’ per questa ragione che le linee guida del Miur, in maniera molto chiara, ci dicono che l'introduzione del corsivo in teoria andrebbe fatta nel secondo anno della primaria.
2) La discriminazione uditiva è la capacità di discriminare i suoni simili. Quindi un bambino che ha difficoltà su questo aspetto potrebbe sviluppare un DSA di tipo verbale. Il segnale predittivo in questo caso è la difficoltà di linguaggio che permane dopo i quattro anni. Da un punto di vista didattico, bambini che dicono cappe per tappe, tattofo per dire carciofo, bucano per dire vulcano, tutti questi bambini, che potrebbero avere delle semplici dislalie, vanno comunque segnalati dall'insegnante, e devono fare un percorso di tipo logopedico; questo perché il perdurare di questo tipo di linguaggio successivamente all’intervento potrebbe segnalare un futuro DSA. Ma è possibile, anche, che un bambino che dice buccano anzichè vulcano abbia una difficoltà nella discriminazione uditiva, cioè non riesca a discriminare i suoni simili: dice la B al posto della V perché non sente la differenza di suono. E’ importante allora proporre un esame audiometrico prima di tutto, poi un trattamento logopedico perché deve impostare bene i suoni simili, li deve discriminare bene.
Sintetizzando, allora, quando noi parliamo di discriminazione uditiva parliamo anche di padronanza fonologica, che è la capacità di percepire riconoscere le diversità dei suoni. Quindi manca la padronanza fonologica quando
- il bambino sostituisce, quando parla, lettere simili come la S e la Z, R e L, D e T,
- omette lettere o patti di parole, e quindi, per esempio, non dice tutta la parola
- Inverte alcune sillabe: poto per topo, cimena per cinema,
- ha difficoltà nell'isolare il primo e l'ultimo suono della parola, abilità che il bambino deve avere a 5 anni.
- ha difficoltà nel riconoscimento e nella costruzione delle rime; anche questa abilità deve essere presente a 5 anni.
Esiste una stretta correlazione tra le competenze metafonologiche, che sarebbe la capacità di riconoscere i suoni delle parole e di manipolarli, e il livello della lettoscrittura.
Se andiamo a vedere gli indicatori che dobbiamo osservare, in base alla letteratura scientificatroviamo:
- un bambino di due anni dovrebbe dire 50 parole.
- sempre a due anni dovrebbe dire frasi di tre parole: “La mamma beve l'acqua”. Non è importante che dica agli articoli, ma la frase dovrebbe contenere tre parole.
- a 3 anni deve saper esprimere esigenze ed emozioni in modo comprensibile e denominare immagini di oggetti comuni su richiesta.
- tra i 3 /4 anni deve articolare le frasi in maniera grammaticalmente corretta. Cioè, se un bambino sta parlando di un evento passato dovrebbe mettere il verbo al passato, anche se non è importante che lo coniughi in maniera esatta, se, invece, sta parlando del futuro dovrebbe mettere un verbo al futuro.
- a 4 anni deve saper fornire un resoconto di un'esperienza recente; quindi, magari il bambino è andato allo zoo e dice,” ieri sono andato allo zoo, ho visto il leone, ho visto le scimmie, sono tornato a casa.” Quindi 3 eventi in successione.
- dai 4 anni deve saper parlare in maniera intelleggibile, cioè che deve farsi capire da tutti, non solo dal genitore o dall’ insegnante che lo vedono tutti i giorni. -
3) Un altro prerequisito importante è la serialità visiva. Per leggere bisogna concentrare l'attenzione su alcuni elementi della stringa di lettere, poi riconoscere e spostare l'attenzione su quelli rimanenti. Questo processo deve avvenire con ordine procedendo da sinistra verso destra in tempi brevi; quando leggiamo mettiamo a fuoco tre o quattro lettere alla volta e ci spostiamo da sinistra verso destra, e facciamo questo in maniera automatica, non controlliamo i movimenti degli occhi, quei movimenti che si chiamano movimenti saccadici. Osservando i movimenti oculari di un normale lettore possiamo notare la messa a fuoco al centro della parola, in maniera abbastanza regolare in una progressione da sinistra a destra. In un lettore con un DSA, generalmente, la messa a fuoco è molto più numerosa. Avviene sopra, sotto, è abbastanza disordinata con la presenza di possibili ripetizioni, ossia a volte il soggetto torna indietro, non procede in maniera automatica da sinistra verso destra e, soprattutto, sulla stessa parola si può fermare più volte. Questa è un'abilità cognitiva che, comunque si può allenare a qualsiasi età
4) Altro prerequisito importantissimo è la memoria e la fusione uditiva. Si tratta della capacità di mantenere in memoria, nella giusta sequenza, lettere che dovranno essere fuse. Ad esempio, per leggere la parola “posacenere ”devo avere la capacità di ritenere, di conservare nella mia memoria a breve termine, 5 elementi in sequenza – po sa ce ne re - sono 5, e non soltanto li devo conservare nella memoria, ma li devo conservare nella giusta sequenza. Lo span di memoria è il numero degli elementi che quella persona riesce a ricordare; si parla per esempio di uno span di tre quando una persona riesce a ricordare tre elementi in sequenza. Tre elementi possono essere tre numeri, tre lettere, tre sillabe, tre parole, eccetera. Un bambino che esce dalla scuola dell'infanzia come competenza attesa deve avere uno span di 5 per poter imparare a leggere e scrivere bene, significa che deve riuscire a conservare nella sua memoria a breve termine 5 elementi nella giusta sequenza, 5 lettere, 5 numeri, 5 sillabe, 5 parole. Se esce dalla scuola dell'infanzia con uno span di quattro potrebbe necessitare anche solo di un po’ d’esercizio sulla memoria uditiva; quando lo span è di 3 allora necessita di un intervento scolastico mirato relativo all’insegnamento della lettura. Da un punto di vista didattico, qualora l’insegnante usasse il metodo letterale, cioè la lettura di una lettera alla volta, è chiaro che quel bambino – span di 3 - potrà leggere solo parole composte da tre lettere. Sarebbe meglio, quindi, con lui utilizzare il metodo fono-sillabico oppure sillabico, dove la sillaba viene lavorata come una singola unità di suono, e quindi dà la possibilità di leggere parole con sei lettere, come salame, o cinema. Questa è la ragione per cui anche le stesse linee guida dicono che il metodo migliore per insegnare la lettoscrittura è proprio quello fono- sillabico, oppure puramente sillabico.
5) La globalità visiva. Secondo uno studio dell’ Università di Cambridge di qualche anno fa, non importa come sono scritte le parole, è importante solo che la prima e l'ultima lettera siano al posto giusto. Il resto non conta. Il cervello è comunque sempre in grado di decifrare tutto questo caos, perché non legge ogni singola lettera ma legge la parola nel suo insieme. Questa è la dimostrazione maggiore che uno dei prerequisiti per la lettoscrittura è la globalità visiva.
Ed allora, cosa fare entro la metà del primo anno della scuola primaria?
- Gli insegnanti devono rilevare le difficoltà di letto- scrittura
- quindi devono vedere se c'è una difficoltà nelle associazione grafema- fonema o
- mancato raggiungimento del controllo sillabico,
- eccessiva lentezza nella lettura e scrittura,
- incapacità di produrre lettere in stampato maiuscolo in modo riconoscibile.
E come fare l'individuazione precoce?
- a 5 anni si può fare un test sui prerequisiti, test che potrebbe essere il PRCR 2.
- In prima elementare si possono proporre le prove MT di prima e seconda elementare,
Queste prove possono essere fatte da psicologi, terapisti, logopedisti e insegnanti.
Anzi, in una scuola pienamente funzionale l'insegnante formato dovrebbe conoscere questi strumenti di screening e proporli a tutti i suoi alunni.
Naturalmente dobbiamo distinguere tra il fare una semplice lavoro di screening, un progetto da proporre a scuola, dalla valutazione clinica, per la quale le linee guida ci dicono che bisogna fare un cognitivo che va a valutare sia la parte verbale che la parte non verbale. Secondo me lo strumento migliore è la wish, un test cognitivo che valuta anche i Q.I.
Poiché i test per la valutazione dei prerequisiti sono rivolti a bambini entro la seconda primaria, nel caso occorra fare una valutazione ad un bambino più grande, cosa possiamo fare?
Possiamo usare sempre, ad esempio, il PRCR ma in maniera “qualitativa” perché la non abbiamo la griglia per fare la standardizzazione dei risultati, per fare la conversione dei punteggi, per bambini più grandi: posto che per leggere devi avere tutti questi prerequisiti, se il bambino legge male qualcosa gli manca e bisogna andare a vedere cosa.
Bisogna specificare che non basta che manchi un prerequisito per dire che siamo in presenza di un DSA, significa solo che bisogna lavorare su un aspetto specifico dei prerequisiti dell’apprendimento, con i genitori e con gli insegnanti.
Naturalmente è importante capire che tipo di DSA io ho davanti, verbale o non verbale, per la proposta del giusto trattamento e di strumenti compensativi appropriati.
Ed è una valutazione che per primi devono fare i clinici, perché è il clinico che deve dire:” il problema è qui e bisogna lavorare su questo aspetto.”
Per esemplificare, relativamente ad un DSA è di tipo verbale, se nello specifico il problema è nel magazzino, nella memoria fonologica, con quel tipo di ragazzini il lavoro che bisogna fare, da terapista, è proprio quello di allenare la memoria in maniera certosina, specifica, senza proporre altri lavori inutili per il ragazzo ( ad es, sulla serialità visiva).
Nella maggior parte dei casi, i DSA sono misti.
Le indicazioni di trattamento, in questo caso, sono relative alla gravità del disturbo ed alla difficoltà di trattarlo. Il clinico devo fare una scelta, ed è chiaro che di fronte ad abilità più difficilmente recuperabili è necessario l’intervento precoce: le abilità più difficilmente recuperabili sono le capacità visuo- percettive, e quindi se manca la capacità di analisi visiva, è necessario intervenire al più presto su questo aspetto perché è un'abilità di difficile recupero. La memoria uditiva segue lo stesso principio: sarebbe meglio intervenire sulla memoria a 5 anni in prima, o in seconda elementare. Meno difficili da potenziare sono le abilità fonologiche sono difficili da potenziare, però comunque lo devo fare sempre presto, 5 anni, sei anni. La serialità visiva, invece, si può allenare sempre, anche in età adulta.
Naturalmente l’intervento terapeutico non dovrà dimenticare il lavoro anche sulla parte emotiva e sulla parte della consapevolezza e autostima per abbattere la famosa muraglia dell'impotenza appresa, l’abbattimento della quale porta, di per se, notevoli miglioramenti nelle capacità di apprendimento del bambino.
I prerequisiti delle competenze di numero e calcolo
La discalculia è un disturbo degli apprendimenti dei concetti logico matematici che porta a difficoltà nell'attività di calcolo o della scrittura o lettura del numero. Nello specifico il bambino
- può fare errori o essere lento nel comprendere il significato dei numeri e quindi calcolare la numerosità, la comparazione, quindi capire qual è il numero più grande, e la seriazione, ossia mettere in ordine i numeri.
- nel leggere e scrivere i numeri può confondere:
- cifre simili ma orientate diversamente (9, 6);
- coppie di numeri leggermente somiglianti tra loro (1,7- 3,5);
- l'organizzazione sequenziale dei numeri (21 e 12);
- l'elencazione dei numeri in avanti e dietro.
- Inoltre può avere difficoltà nel fare i calcoli a mente o per iscritto, difficoltà con l’incolonnamento, col riporto, a dare il giusto significato ai segni (+, X, -).
Nelle linee guida del Miur, è stato evidenziato come nel primo biennio della scuola elementare, il 20% degli alunni ha difficoltà nella lettura, scrittura e calcolo, ed invita, anche per la matematica a soffermarsi sui prerequisiti, perché anche lì ci possono essere dei segnali d'allarme.
- Uno di questi prerequisiti è la memoria. Sicuramente un bambino che ha un problema di memoria a 4 o 5 anni potrebbe avere problemi nella lettura, ma anche nella matematica. Si evidenzia una stretta correlazione tra la memoria di lavoro e gli apprendimenti scolastici, una correlazione talmente stretta che la memoria di lavoro uditiva diventa un valore predittivo. Che vuol dire? Vuol dire che se io volessi conoscere quale potrebbe essere il rendimento scolastico di un bambino di prima elementare, uno dei valori che andrò a valutare nel test cognitivo sarà proprio la memoria di lavoro: una valutazione della memoria di lavoro sotto la media a 5 o 6 anni può essere predittiva di un percorso scolastico con difficoltà sia nello studio della matematica, sia nella comprensione del testo. Quindi a proposito della memoria di lavoro, andremo a vedere gli SPAN, cioè il numero di elementi che si riescono a ricordare in sequenza.
Lo span può essere:
- “uditivo orale,” cioè relativo a ripetizione a seguito di parole dette, e deve essere, a 5 anni, almeno di 5.
- “visivo orale”, cioè il bambino vede e ripete.
- “visivo scritto”: il bambino vede e scrive. E’ importante che ripetano nella giusta sequenza.
Per meglio chiarire gli altri prerequisiti del calcolo è utile partire dalla BIN, batteria per la valutazione dell'intelligenza numerica, che si adotta per i bambini dai 4 ai 6 anni.
La teoria che sta alla base di questo strumento ci dice che per fare i calcoli abbiamo bisogno, prima, di acquisire alcune competenze che riguardano l'elaborazione dei numeri e quindi:
- prima di tutto bisogna aver acquisito i processi semantici che riguardano il confronto tra quantità, per capire qual è l'insieme che ne ha di più o di meno, e numeri , per capire qual è il numero più grande.
- poi abbiamo i processi lessicali, relativi la capacità di riconoscere i numeri, leggerli e scriverli.
- poi ci sono i processi sintattici o pre-sintattici, ossia la capacità di associare a quel numero la quantità, cioè sapere, per esempio, che 3 numero arabico vuole corrispondere a tre cose, a tre oggetti. Questa è l'associazione tra numero e quantità. Sempre tra i processi sintattici, poi abbiamo la capacità di capire gli ordini di grandezza, cioè qual è un numero più grande e qual è un numero più piccolo.
Questi tre processi, semantici, lessicali e sintattici, si chiamano processi di elaborazione dei numeri.
- Poi abbiamo il counting, cioè il contare, la capacità di numerare in avanti e indietro e di fare delle seriazioni.
Solo dopo aver imparato a contare si è nella condizione per iniziare a fare i calcoli a mente, perché è il conteggio che lega i processi di elaborazione dei numeri a quello del calcolo.
Ed allora sono stati individuati gli ulteriori (alla memoria) prerequisiti delle competenze di numero e di calcolo: processo semantico, lessicale, sintattico, il counting, il calcolo a mente e calcolo scritto.
- Abbiamo detto che i processi semantici sono quei processi che aiutano a confrontare le quantità per capire dove c'è ne sono di più e dove ne sono di meno; per esempio nel BIN va presentato al bambino un cartoncino dove ci sono dei puntini e la domanda è:” dove ci sono più pallini? “ Che cosa andiamo a valutare? La percezione della quantità; non è necessario, che il bambino faccia la conta. Il test vuole valutare solo quanto, a livello visuo- percettivo, il bambino riesca a fare una stima. Un bambino di 4/5 anni dovrebbe riuscire a fare questa stima. E’ importante, inoltre, che il bambino abbia capito che indipendentemente dalle caratteristiche fisiche degli oggetti, la numerosità non cambia. Quindi io posso avere quattro oggetti grandi e quattro oggetti piccoli, e sapere che, anche se a livello fisico sono completamente diversi, la numerosità e la stessa. Per capire questo concetto ci vuole un buon livello di astrazione. Un bambino che ha una compromissione cognitiva e ha un problema di astrazione si legherà molto alle caratteristiche fisiche degli oggetti - intendo la forma, la dimensione, il colore - non riuscendo ad andare al suo significato numericamente intrinseco. Non è detto che per lui quattro palloncini piccoli, siano numericamente come quattro dita della mano anche se sono di un'altra forma: sono cose diverse.
Sempre tra processi semantici, c'è la capacità di confronto tra numeri arabi, ossia di effettuare il confronto usando una rappresentazione mentale del numero, cioè usando il codice arabo.
- I processi lessicali determinano la capacità di individuare il numero, leggerlo e scriverlo, in poche parole la capacità del bambino di padroneggiare il codice numerico arabo. Per esemplificare di fronte ad un cartoncino con su scritti tre numeri, ad esempio, il bambino deve saper riconoscere il numero 1.
- Riguardo ai processi sintattici o presintattici, una prima abilità è la capacità di far corrispondere un codice arabo alla quantità. Si tratta, in definitiva, della capacità di usare le regole del sistema numerico, le quali organizzano i sistemi di grandezza e i rispettivi codici verbali e scritti. E’ una abilità che sin dalla nascita abbiamo dentro di noi, “l'istinto di contabilizzazione” , che vuol dire che se noi, per esempio, vediamo tre persone che stanno arrivando, riusciamo a capire che sono tre ancor prima di capire che cosa sono, cioè noi percepiamo prima la numerosità che non le caratteristiche fisiche. Bisogna precisare come sia una abilità differente da quella di contare 1,2,3,4,5…imparando i numeri come una filastrocca, in questo caso il bambino deve conoscere la corrispondenza del numero alla quantità: 5 significa che ci sono 5 cose….Naturalmente, qualora il bambino non sia in grado di riconoscere il numero, allora ci troviamo di fronte ad un problema lessicale e non sintattico. Questa è una abilità che deve sapersi esprimere intorno ai 4 anni. Sempre tra i processi sintattici importante è capire anche l'ordine di grandezza, cioè riuscire ad ordinare le dimensioni o le quantità secondo la loro grandezza.
- Il counting è conseguente all’ordine di grandezza ed indica, in prima battuta, la capacità di ricostruire e mantenere la corretta sequenza in avanti. Ma indica anche l’acquisizione del concetto dell’ordine stabile implicato nel conteggio, e cioè che i numeri occupano sempre la stessa posizione nella sequenza. Sintetizzando, saper contare implica il principio della cardinalità del numero. Il bambino inizialmente pronuncia le parole del numero come se fosse una filastrocca. In un secondo momento capisce che c'è una corrispondenza biunivoca tra un numero e la quantità corrispondente, cioè fa corrispondere la parola numero ad uno ed un solo elemento dell'insieme di oggetti che sta contando.
L'astrazione si riferisce al fatto che il bambino comprende di poter applicare la conta a qualsiasi insieme di oggetti, a prescindere dalle caratteristiche fisiche degli stessi. Quindi il bambino capisce che 3 è 3 se io lo faccio con le mani, se lo faccio con le palline, eccetera. È un principio che il bambino apprende anche osservando gli adulti che usano il contare in una pluralità di situazioni. Qualora avesse un problema di astrazione il bambino rimarrà ancorato alle caratteristiche fisiche, quindi alla dimensione, alla forma, al colore e non andrà, non accederà alla categoria superiore della numerosità.
Un'altra cosa importante è l'irrilevanza dell'ordine: la numerosità di un insieme non cambia, se si cambia il punto di partenza della conta. Per capire meglio, se metto davanti ad un bambino 10 carte e gli dico di partire dalla quarta carta, lui deve iniziare a conteggiare 4,5,6…. a 5 anni è una abilità che dovrebbe essere acquisita.
Un 'altra abilità che ci aiuta molto, relativa soprattutto alla teoria di Kaufman, è il subitizing, quel processo mentale attraverso il quale noi determiniamo un insieme di numeri senza contarli. Normalmente il subitizing si attiva solo con insiemi di 5 o meno di 5, con insiemi maggiori di 5 è molto difficile. Significa che se vediamo quattro parole scritte sulla lavagna io non le devo contare, so già che sono quattro, cioè faccio un riconoscimento percettivo immediato della quantità. E’ un’abilità che di solito acquisiamo da soli, ma può mancare in alcuni bambini, rispetto ai quali si può attivare un percorso di sostegno.
- Calcolo a mente significa che non è scritto, sostanzialmente, cioè che non si possono tenere nota dei numeri con cui si sta operando, del segno, insomma della procedura che viene chiesta. Però poi si deve saper risolvere l’operazione di calcolo come meglio si crede, quindi secondo una strategia, quale che sia, che funzioni. Nel calcolo a mente, noi tutti usiamo degli automatismi, delle scorciatoie, che naturalmente ai bambini che hanno difficoltà di calcolo bisogna insegnare.
- Il calcolo scritto. Le conoscenze procedurali che riguardano l'esecuzione del calcolo scritto sono estremamente enfatizzate nei programmi, nelle linee guida ministeriali che lo definiscono come l’ “ apprendimento di procedure necessarie per eseguire calcoli molto complessi, che abbisognano di un supporto cartaceo per dare aiuto al nostro sistema di memoria. Quindi, il calcolo scritto ha il compito di automatizzare procedure ed algoritmi e non quello di sviluppare strategie né di potenziare le abilità di intelligenza numerica”. L'algoritmo dello svolgimento di un calcolo scritto è fatto di sintassi, cioè delle regole di procedimento: vado davanti da destra a sinistra, procedo con il prestito, riporto ……, ma poi c'è il capire quello che facciamo, l’idea sottesa alla procedura, e questo capire è sempre poco allenato a scuola. Ma se non capiamo è facile fare errori di sistema. Le conoscenze necessarie allo svolgimento del compito scritto sono la comprensione dei numeri arabi, saperli scrivere, riconoscere il segno aritmetico, recuperare i fatti aritmetici, saper organizzare lo spazio di scrittura.
In conclusione, brevemente lo screaning.
- Entro la metà del primo anno della scuola primaria gli insegnanti devono rilevare se c'è un problema di calcolo, difficoltà nel riconoscimento di piccole quantità, difficoltà nella lettura e scrittura dei numeri entro il 10, difficoltà nel calcolo orale entro la decina, anche con supporto concreto, cioè con le dita.
- Nelle linee guida il miur dice che nella scuola primaria prima di tutto bisogna sviluppare la comprensione della connessione numero - quantità, porre attenzione all'abilità di conteggio da esercitare in condizioni ludiche, con le carte, con i dadi, eccetera, avviare al calcolo a mente per l'evoluzione dell'intelligenza numerica.
- Nella discalculia evolutiva il disturbo riguarda le abilità di base, quindi i numeri fino a sei cifre, il calcolo mentale entro il 100, l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione. La divisione non viene proprio presa in considerazione perché la divisione è una abilità complessa nei confronti della quale le difficoltà che si presentano non sono necessariamente legate ad una discalculia.
Federica Agovino
Psicoterapeuta

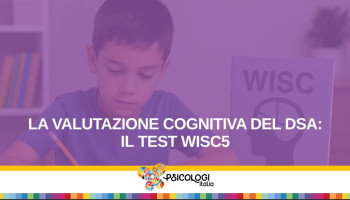
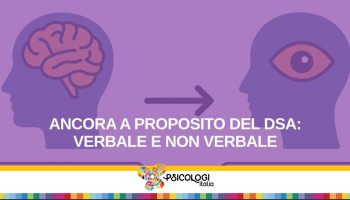



commenta questa pubblicazione
Sii il primo a commentare questo articolo...
Clicca qui per inserire un commento