Cercherò di spiegare perché una diagnosi precoce dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) è così importante, e per fare questo iniziamo col conoscere le previsioni normative e le indicazioni di prassi che regolano l’intervento specialistico.
Iniziando dalla legge 170 del 2010, questa prevede come “è compito” -quindi non ci troviamo di fronte alla possibilità di una valutazione discrezionale - “dell'insegnante, segnalare se c'è una difficoltà”: è un dovere, e quindi la legge cambia completamente la prospettiva precedente.
Nel 2011 le linee guida allegate alla L.170 specificano, per esempio, quello che può succedere nella scuola dell'infanzia: “Il bambino che confonde i suoni, non completa le frasi, utilizza parole non adeguate al contesto, le sostituisce, omette suoni o mette parti di parole, sostituisce i suoni, le lettere, comunque ha un'espressione linguistica inadeguata, va supportato con attività personalizzate all'interno del gruppo.”
Quindi già dal 2011 si inizia a parlare di laboratori di potenziamento all'interno proprio del gruppo classe.
Poi “si dovrà privilegiare l'uso di metodologia di carattere operativo su quelle di carattere trasmissivo, dare importanza all'attività psicomotoria….poiché ….l'uso eccessivo di schede prestampate smorza la creatività, l'espressività del bambino”, specificando, quindi, come si ritenga molto importante far vivere, per esemplificare, le lettere, i suoni, i numeri eccetera, attraverso delle attività psicomotorie, attraverso il movimento, invece che passare direttamente e soltanto alle schede.
L’attribuzione alle scuole, compresa la scuola dell’infanzia, della responsabilità di segnalare casi sospetti, ed il conseguente aumento vertiginoso di segnalazioni, costringe il ministero dell’istruzione (Decreto MIUR 17.04.2013, prot. n. 297. Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA) ad una specificazione riguardo alle responsabilità della segnalazione e di intervento delle scuole: “Le difficoltà eventualmente emerse dalle attività di identificazione non debbono portare all'invio dei bambini al servizio sanitario, ma ad un aumento dell'attenzione ed alla proposta di specifiche attività educative e didattiche. Si sottolinea, al riguardo, che nella scuola dell’infanzia non è previsto effettuare invii al servizio specialistico per un sospetto di DSA”.
In concreto, l’insegnante non può chiedere una valutazione perché quel bambino “potrebbe avere disturbi di apprendimento”, ma deve, nell’evidenza di difficoltà, ad esempio, nel linguaggio, a livello visivo -spaziale, a livello psicomotorio, nel coordinamento, proporre specifiche attività educative e percorsi di potenziamento.
Quindi, volendo ricapitolare qual è l'iter previsto dalle linee guida per la individuazione degli alunni che presentano difficoltà:
1- Questa individuazione va fatta per i bambini di 5 anni, prima e seconda elementare.
2- Individuati questi bambini l’insegnante deve mettere in atto laboratori di potenziamento mirati; questi lavori non devono essere individuali ma proposti all'interno del gruppo classe, perché in ogni caso fanno bene a tutti, anche ai compagni che non hanno difficoltà.
3- Messo in atto un laboratorio di potenziamento, e verificato che dopo almeno tre mesi non ci sono stati da parte dei bambini dei grandi miglioramenti, allora solamente a quel punto vanno segnalati i bambini resistenti all'intervento didattico.
Quindi le linee guida hanno rimodulato le indicazioni della L. 170 che prevedeva la segnalazione immediata da parte dell’insegnante dando istruzioni didattiche con la possibilità di chiedere, solo successivamente ed eventualmente, un approfondimento diagnostico.
Cosa ne deriva?
- Compiti e responsabilità per la scuola
- Attenzione alla fase della valutazione
- Misure formative necessarie per il personale docente e dirigenziale in ambito scolastico sui DSA
- Utilizzo di modalità individualizzate e flessibili (strumenti dispensativi e compensativi, che diventano d’obbligo in presenza di certificazione) nell'approccio a soggetti con DSA nonché all'utilizzo di strumenti compensativi volti a favorire l'apprendimento
Passando ad individuare i compiti e le responsabilità per la scuola d’infanzia, questi sono:
- l'osservazione sistematica (cosa osservare, in che tempi ed in che modo) con griglie di osservazione che la rendano almeno in parte oggettiva;
- attività di potenziamento mirate;
- e naturalmente una formazione specifica degli insegnanti
Ne consegue che la mancata osservazione delle indicazioni delle linee guida implica la responsabilità civile/amministrativa dei dirigenti scolastici e degli insegnanti.
A chi va fatta la segnalazione? Ai genitori nell’occasione di una riunione che veda presenti anche la dirigenza ed i professori e della quale venga redatto verbale; questo perché può succedere è che magari l'insegnante lo dice al genitore il quale però non è ancora pronto, non ha accettato la difficoltà del figlio, la nega e non attiva il percorso di aiuto.
Per quanto riguarda invece la scuola primaria e secondaria, i compiti e le responsabilità sono:
- attenta valutazione delle difficoltà dello studente;
- nel caso in cui si rilevano delle difficoltà, dei DSA, utilizzazione di misure dispensative e compensative;
- e poi, di nuovo, la formazione.
Ma perché tutto questo? Perché è scritto nelle varie linee guida che è importante partire da un'osservazione sistematica?
Perché si è riscontrato che proprio le osservazioni fatte dalle insegnanti sul comportamento dei bambini nella scuola dell'infanzia possono essere altamente predittivi rispetto allo sviluppo di una successiva difficoltà nell'apprendimento.
Ed è importante intervenire precocemente perché nei disturbi di apprendimento è stata ormai accertata una interdipendenza tra le varie componenti, tra le componenti cognitive, emotive, motivazionali e relazionali con la conseguenza che prestazioni altalenanti nell’ambito dell’apprendimento scolastico possono generare problemi di autostima, problemi motivazionali, atteggiamenti di chiusura con conseguenti problematiche relazionali e sociali soprattutto quando il disturbo è molto importante, molto compromesso, inizierà anche ad avere un atteggiamento di chiusura a livello sociale.
Infatti, l'80% dei bambini che hanno un DSA presentano anche:
- problemi motivazionali, quindi si sentono meno responsabili del loro apprendimento, persistono poco di fronte a un compito, hanno una sfiducia nelle proprie possibilità di imparare
- problemi emotivi, quindi un concetto di sé più negativo, una maggiore ansia e una bassa autostima e
- problemi relazionali, difficoltà ad entrare in relazioni con i compagni: sono più facilmente esclusi e respinti.
Nella pratica, una diagnosi e un intervento precoce permettono di modificare la traiettoria evolutiva dello studente, riducendo le probabilità di insorgenza di disturbi più invalidanti e di conseguenze emotive negative. È quindi fondamentale non aspettare che emergano segnali evidenti di DSA, ma monitorare e intervenire in modo sistematico fin dai primi anni di scuola, anche attraverso attività di potenziamento e osservazione accurata. Ed allora, con l’intervento precoce, facendo un lavoro di potenziamento possiamo contribuire anche ad evitare questi altri problemi che sono molto importanti e difficili poi da scardinare una volta in impostati.
Una ricerca di Shaywitz e Morris (2008) ha verificato anche come un intervento precoce abbassi al di sotto del 5% la percentuale dei bambini a rischio dislessia, e comunque contribuisca ad un abbassamento del livello di difficoltà; e nella vita di uno studente è differente avere un DSA grave o un DSA lieve in quanto il percorso scolastico è completamente diverso.
E già in età prescolare noi possiamo osservare degli indicatori di rischio:
- La familiarità; il DSA ha una predisposizione genetica, quindi è molto importante fare anche una piccola anamnesi sul percorso scolastico dei genitori, perché molto spesso c'è appunto anche da parte dei genitori una certa difficoltà a livello scolastico.
- Altro fattore di rischio sono l’aver subito 2 o e 3 anestesie prima dei quattro anni. Qui il principio è che noi fino a 4, 5 anni abbiamo una buona plasticità cerebrale che può essere cambiata sia in positivo che in negativo: sicuramente prendere alcuni farmaci nei primi anni di vita fa la differenza.
- La prematurità e il basso peso dalla nascita è un altro indicatore di rischio sempre per il principio esposto prima: spesso il bambino che ha che nasce prematuro ha bisogno di fare tutta una serie di interventi, e questi interventi comportano comunque anche l’assunzione di farmaci che hanno un impatto ha un impatto sulla plasticità cerebrale.
- Difficoltà nelle competenze comunicativo-linguistiche.
- Avere una difficoltà a livello motorio prassico.
- Avere una difficoltà a livello visuo-spaziale.
Questi sono tutti elementi che andranno riportati nella eventuale relazione.
Per quanto riguarda la regione Lazio, la regione in cui esercito la professione, questa ha predisposto un modello di certificazione DSA, divisa in due parti, la prima parte è la versione per la scuola, la seconda parte è la versione per il clinico. Nella seconda parte c’è proprio un riquadro dedicato agli indicatori di rischio dove vanno riportati se si sono rilevati e quali sono gli indicatori di rischio, e quindi la familiarità, se ha preso dei farmaci, se è stato segnalato a scuola dell'infanzia per delle difficoltà di linguaggio eccetera.
Per quanto riguarda i tempi della diagnosi, con riguardo al la dislessia, disgrafia e disortografia, questa può essere fatta dal 2° anno della scuola primaria (coincide con il completamento del ciclo dell’istruzione formale del codice scritto); si può fare diagnosi alla fine del 1° anno della scuola primaria nelle ipotesi di profili funzionali molto compromessi, di pregresso disturbo del linguaggio, di familiarità accertata per il disturbo di lettura.
Per quanto riguarda, invece, la discalculia è possibile fare diagnosi dalla fine della 3° anno della scuola primaria.
Federica Agovino
Psicoterapeuta

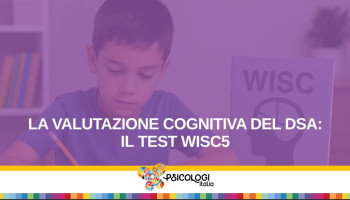
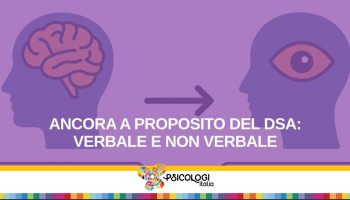



commenta questa pubblicazione
Sii il primo a commentare questo articolo...
Clicca qui per inserire un commento