In un’epoca in cui l’interconnessione è immediata ma spesso superficiale, la paura della solitudine emerge come un’ombra silenziosa che accompagna molti percorsi di vita. Non si tratta soltanto dell’assenza di compagnia, ma del timore più profondo di non esistere se non nello sguardo dell’altro. Da questa ferita emotiva nasce la rincorsa del legame, un impulso che ci spinge a cercare nell’altro la conferma del nostro valore e la garanzia della nostra esistenza.
Radici antiche: l’attaccamento e le prime esperienze affettive
Il bisogno di connessione è inscritto nella natura umana. I primi legami con le figure di riferimento plasmano il modo in cui ci relazioniamo nel tempo con la solitudine e l’intimità. Quando l’amore viene percepito come condizionato o incostante, può radicarsi l’idea che l’amore vada “guadagnato”, e che da soli si sia incompleti. Questo schema può accompagnare la persona per anni, influenzando relazioni, scelte, e persino l’autostima.
L’attaccamento è il cuore pulsante delle nostre relazioni: è il modo in cui impariamo a sentire sicurezza, amore e connessione con gli altri. La teoria dell’attaccamento, sviluppata da John Bowlby e poi approfondita da Mary Ainsworth, spiega come le esperienze affettive nei primi anni di vita influenzino profondamente il modo in cui ci relazioniamo da adulti.
L'attaccamento, un meccanismo psicologico antico quanto l’essere umano, che si forma nei primi anni di vita e che, spesso senza che ce ne rendiamo conto, guida le nostre scelte affettive, le nostre paure più intime e il nostro modo di stare in relazione con gli altri.
Comprendere il proprio stile di attaccamento non è solo un esercizio teorico, ma un atto trasformativo: significa guardarsi dentro con onestà, riconoscere i modelli appresi e, se necessario, costruirne di nuovi. È un tema che riguarda tutti, perché tutti – prima ancora di essere adulti, professionisti, partner o genitori – siamo stati bambini in cerca di sicurezza, amore e riconoscimento.
La rincorsa dell’altro: tra bisogno e dipendenza
Quando la paura del vuoto prende il sopravvento, si rischia di costruire relazioni fondate più sulla necessità che sulla condivisione autentica. Il confine tra desiderio e dipendenza si assottiglia: si ha bisogno dell’altro non per chi è, ma per ciò che rappresenta. Questa rincorsa affettiva può portare a dinamiche disfunzionali, come la paura dell’abbandono, il sacrificio costante di sé o la difficoltà a porre limiti emotivi chiari.
Verso l’autonomia affettiva: un processo di riappropriazione
L’autonomia affettiva non significa chiusura o autosufficienza forzata, ma capacità di stare in relazione senza annullarsi. È un cammino di consapevolezza che invita a riconoscere le proprie vulnerabilità, a dare spazio ai bisogni personali, e a nutrire il proprio mondo interno. Imparare a restare soli senza sentirsi soli è uno degli atti più rivoluzionari in un contesto sociale che spesso confonde l’amore con la simbiosi.
Storia di Laura: imparare a restare
Laura ha 32 anni e da sempre teme di restare sola. Ogni relazione amorosa si trasforma in una rincorsa: messaggi continui, richieste di rassicurazione, ansia quando l’altro prende spazio. Quando una storia finisce, crolla. Ma dopo l’ennesima relazione fallita, qualcosa cambia.
Con l’aiuto di una terapeuta, Laura inizia a lavorare su di sé. Si accorge che quella sensazione di vuoto l’ha sempre abitata, molto prima di ogni partner. Ricorda la sua infanzia: una madre emotivamente distante, un padre spesso assente. Si rende conto che ha sempre cercato nell’altro la presenza che le mancava da bambina.
Il suo percorso è lento, fatto di dolore ma anche di scoperta. Impara a distinguere il bisogno d’amore dalla dipendenza affettiva. A stare nella solitudine senza subirla. A scegliere l’altro, non rincorrerlo
Il percorso terapeutico: come si lavora sulla dipendenza affettiva
Un percorso terapeutico efficace lavora su più livelli per affrontare la paura della solitudine e la dipendenza affettiva. Tra i principali obiettivi:
Riconoscere i modelli interiorizzati
Il terapeuta guida la persona a esplorare le prime relazioni significative (genitori, figure di accudimento) per identificare bisogni insoddisfatti e modelli di attaccamento (Bowlby, 1980). Questo aiuta a capire perché si teme l’abbandono e si rincorre l’altro.
Dare spazio all’esperienza emotiva
La terapia permette di contattare il vuoto interno, la vergogna, la paura, senza evitarli. Sentire la solitudine in un contesto sicuro può trasformarla in una risorsa. È il primo passo per non esserne più schiavi.
Lavorare sull’autostima e sull’identità
Molte persone che rincorrono l’altro non hanno una chiara percezione del proprio valore. La terapia rinforza l’identità personale, permette di ricostruire un senso di sé stabile e autonomo.
Allenare i confini relazionali
Il terapeuta aiuta a riconoscere comportamenti di fusione e dipendenza, e a costruire confini affettivi sani, dove l’amore diventa scelta e non bisogno compulsivo.
Integrare nuove modalità relazionali
Con il tempo, la persona impara a vivere le relazioni non più come “salvezza”, ma come esperienza libera e autentica, riducendo l’ansia dell’abbandono e la necessità di rincorrere l’altro per sentirsi vivi.
La trasformazione: dal bisogno alla scelta
Superare la paura della solitudine significa imparare a stare con sé stessi. Non si tratta di rifiutare l’amore, ma di non fondare il proprio valore su di esso.
Chi riesce a restare solo impara a conoscersi, a costruire confini sani, a distinguere l’amore autentico dal legame compulsivo. Da “chi mi completa” si passa a “chi cammina con me”.
Esercizi pratici
Esercizio 1 – Dialogo con la solitudine
Ogni giorno, per una settimana, dedica 10 minuti a stare da solo in silenzio. Nessun telefono, musica o distrazioni. Scrivi poi su un diario: "Come mi sono sentito? Cosa è emerso?"
Scopo: imparare a stare nel vuoto senza evitarlo.
Esercizio 2 – Mappa del mio valore
Fai un elenco di almeno 10 cose che ti rendono una persona di valore, senza includere il giudizio altrui o relazioni. Ad esempio: “sono gentile”, “so ascoltare”, “ho superato momenti difficili”.
Scopo: rinforzare l’autostima indipendente dagli altri.
Esercizio 3 – Riscrivi la tua storia
Pensa a una relazione dove ti sei sentito dipendente. Scrivi una lettera (che non invierai) alla persona coinvolta. In essa, racconta cosa cercavi da lui/lei che in realtà volevi da te stesso.
Scopo: portare alla luce bisogni proiettati sull’altro.
Esercizio 4 – Il giorno solo
Programma una giornata intera da vivere in autonomia. Scegli attività che ti piacciono, mangia da solo in un posto bello, cammina in un parco. Alla fine della giornata, rifletti su cosa ti ha fatto bene e cosa ti ha messo a disagio.
Scopo: trasformare la solitudine in scelta.
Conclusioni
La solitudine può diventare uno spazio fertile se impariamo ad abitarla con amore e curiosità. In questo spazio nasce la possibilità di amare senza dipendere, di essere con l’altro senza perdersi. È lì che fiorisce la vera intimità: quella tra due persone intere, capaci di scegliersi ogni giorno non per necessità, ma per desiderio autentico di condividere il proprio cammino.
Dott.ssa Antonella Bellanzon
Bibliografia e riferimenti
-
Bowlby, J. (1980). Attaccamento e perdita. Vol. 1: L’attaccamento alla madre. Raffaello Cortina.
-
Norwood, R. (1985). Donne che amano troppo. Feltrinelli.
-
Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529.
-
Gabor Maté (2021). Il mito della normalità: trauma, malattia e guarigione in una società tossica. Edizioni Tlon.
-
Bell Hooks (2000). All About Love: New Visions. Harper Perennial.
-
Pellai, A. & Tamborini, B. (2020). Il metodo famiglia felice. DeAgostini.
-
Winnicott, D. W. (1958). La capacità di essere soli. In Colloqui con i genitori. Armando Editore.


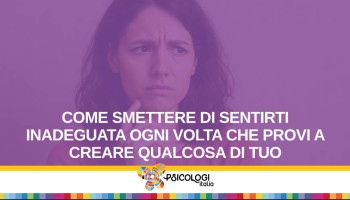
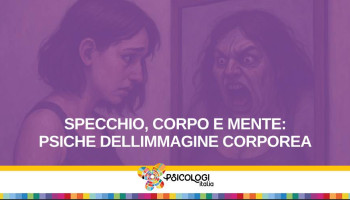
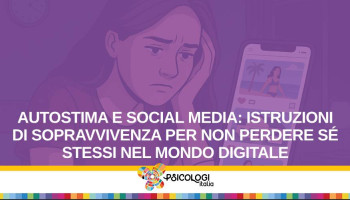
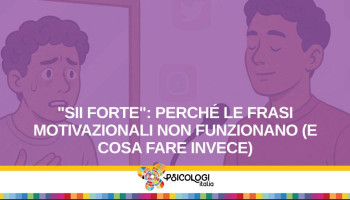
commenta questa pubblicazione
Sii il primo a commentare questo articolo...
Clicca qui per inserire un commento