Introduzione all’isteria
Isteria è un termine che deriva dal greco “hystera”, utero, ed indica una condizione psicopatologica in passato considerata tipicamente femminile. Charcot, durante i suoi anni all’ospedale La Salpetrière, ne aveva studiato le sue manifestazioni più eclatanti: convulsioni, zone isterogene, paralisi non neurogene. L’etiologia di tale psicopatologia era riconducibile alla degenerazione, ovvero quell’alterazione fisica che colpisce un soggetto e si trasmette alle successive generazioni per via ereditaria. Questa degenerazione verrebbe “attivata” da un evento traumatico, senza il quale non vi sarebbero state manifestazioni di isteria. Per quanto possa sembrare datato, questo concetto è estremamente attuale ed in termini contemporanei lo tradurremmo con: la predisposizione genetica sommata ad un fattore scatenante induce l’insorgenza della sintomatologia. Charcot non disse nulla di diverso di quanto la moderna epigenetica afferma.
Per il trattamento dell’isteria Breuer proponeva l’uso dell’ipnosi, tramite la quale la paziente poteva essere ricondotta “alla preistoria psichica del suo disturbo, costringendola a riconoscere l’occasione psichica che ha scatenato il disturbo in questione” (Freud, Isteria, 1888).
Il pensiero di Freud
In Comunicazione preliminare lo stesso Freud, però, iniziò a rifiutare l’idea che alla base dell’isteria vi fosse una condizione prevalentemente genetica, ritenendo che l’elemento fondamentale fosse l’esperienza traumatica. Freud ritenne che a scatenare l’isteria potesse essere un singolo evento traumatico, oppure una serie di eventi traumatici “parziali”, ripetuti nel tempo. Ed è qui che si nota una prima anticipazione di quanto sarebbe stato scoperto anni a venire: in questa opera vennero anticipati gli attuali concetti di “potere cumulativo del trauma” e “trauma cronico”. Proseguendo nella teoria freudiana, i traumi parziali con il tempo acquisiscono la giusta quantità di “eccitamento” : l’evento traumatico eccita il sistema nervoso in modo eccessivo, e tale energia non trova modo per essere scaricata. Poiché la psiche tende a mantenere una “somma di eccitamento” costantemente bassa, secondo il principio di costanza, la sovrastimolazione va scaricata mediante una reazione motoria, ovvero il sintomo isterico.
La tecnica dell’ipnosi proposta da Breuer vede, in virtù di questa nuova prospettiva, un diverso significato: ricondurre la persona all’origine della sua isteria, scavando in quell’area della psiche che sfugge la coscienza, per verbalizzare l’accaduto e consentire quel processo di scarica (abreazione) che permette di sottostare al principio di costanza.
La nuova prospettiva: nuove aree di ricerca e la teoria della seduzione
Nel 1896 Freud pubblica un manoscritto rivoluzionario per la sua teoria sull’origine dell’isteria, cui affianca le riflessioni sulla Teoria della Seduzione condivise con il suo amico Fliess. Parliamo di L’eredità e l’etiologia delle nevrosi e della Minuta K.
Nel primo scritto l’autore afferma che certamente una parte dei casi di isteria sono dovuti a fattori ereditari, ma nella maggior parte dei casi non è la degenerazione ad esserne la causa, bensì la sessualità. Nascono così due nuove categorie di nevrosi: le nevrosi attuali sono la nevrastenia e la nevrosi d’angoscia, causate da eccessiva masturbazione la prima, coito interrotto la seconda, e sono relative ad un’anomala sessualità del presente. Le nevrosi da difesa, invece, sono riconducibili al passato, ed includono fuga nella psicosi, nevrosi ossessiva, isteria.
In questi casi si riscontra un evento traumatico in diversi periodi dell’infanzia, e a seconda della fascia d’età in cui questo occorre, si avranno esiti differenti: se il trauma occorre verso i due anni produrrà allucinazioni di tipo psicotico, se occorre verso i cinque-sei anni darà origine all’isteria, se occorre verso i dieci anni produrrà la nevrosi ossessiva.
Freud aveva così anticipato il concetto di periodo critico, ovvero quell’arco temporale in cui l’esposizione a specifiche esperienze è determinante per lo sviluppo di particolari abilità e funzioni cognitive. In Freud, potremmo vederlo come un periodo in cui l’esposizione traumatica alla sessualità determina lo sviluppo di una psicopatologia piuttosto che un’altra.
Ma cosa accade esattamente?
Secondo la teoria della seduzione, rivista e poi abbandonata, un evento seduttivo da parte di un adulto si verificherebbe nell’infanzia del bambino. Questo sarebbe registrato nel sistema nervoso mediante l’attivazione di specifiche connessioni ed inducendo uno stato di iperattivazione dovuta all’incompatibilità dell’evento con la coscienza. In virtù del principio di costanza è necessario intervenire con delle difese: la scissione permetterà la separazione della traccia mnestica (la pura narrazione dell’evento) e dell’affetto (l’attivazione emotiva ad esso associata); il primo sarà rimosso e rilegato nell’inconscio, il secondo rimarrà latente.
Quando in età puberale il soggetto si avvicinerà alla stimolazione genitale, benchè la traccia mnestica rimanga inconscia si riattiverà la traccia affettiva. Sarà allora necessario intervenire di nuovo, tramite altre difese, per ridurre la somma d’eccitamento.
A seconda della difesa e dell’età in cui si verifica il trauma si avranno diversi esiti:
- 2-3 anni: il livello di eccitamento e di affetto sono intollerabili, l’unico modo per sopravvivere è il diniego dell’esperienza, che induce alla fuga psicotica.
- 5-6 anni: nei soggetti propensi all’uso della difesa di conversione, l’affetto viene trasformato in sintomo somatico.
- 8-10 anni: nei soggetti non propensi all’uso della conversione, l’affetto sarà trasformato, mediante formazione reattiva, in un’ossessione.
Ma perché il tutto si riattiva in età puberale?
Freud dice:
“Proprio perché si tratta di un soggetto in età infantile, l’irritazione sessuale precoce non produce alcun effetto. […]Più tardi, quando le reattività degli organi sessuali del soggetto in età puberale si sarà sviluppata […] il ricordo svilupperà una potenza che era del tutto assente nell’episodio originario.” (Freud, L’ereditarietà e l’etiologia delle nevrosi, pag. 208)
Anche in questo caso ci si ritrova di fronte a qualcosa di assolutamente attuale: la psicologia dello sviluppo insegna che le risorse cognitive di cui il bambino dispone cambiano nel corso degli anni, con la sua crescita. Un evento traumatico avvenuto in età infantile sarà interpretato e compreso diversamente da uno avvenuto in epoche successive. Freud asserisce proprio questo: a seconda della capacità che il bambino ha di spiegarsi l’evento seduttivo, e delle difese di cui dispone in quel momento evolutivo, svilupperà una diversa psicopatologia il cui scopo è non farsi distruggere da quello che poi lo stesso autore definirà Thanathos.
D’altronde, Teicher e Samson nel 2016 hanno dimostrato come nei cervelli di soggetti con esperienze traumatiche in età infantile (in particolare di abuso) vi siano delle anomale attivazioni responsabili, insieme ad una certa predisposizione genetica, della nascita di psicopatologie varie, un tentativo inconscio del soggetto di difendersi da una “rappresentazione incompatibile”.
Conclusione
Ripercorrere l’evoluzione del pensiero freudiano non è facile: la produzione letteraria di Freud è molto vasta ed articolata, vede delle affermazioni seguite da smentite, momenti di sviluppo e momenti in cui “si aggiusta il tiro”.
I cambiamenti storico-culturali, i nuovi approcci e le nuove istanze provenienti dalla società, che richiedeva una psicologia sempre più “scientifica e meno filosofica” hanno portato ad un alone di critiche che, impietoso, si è steso sull’intera produzione freudiana.
Superato, sbagliato, non al passo con i tempi, pieno di fandonie. Sono solo alcuni dei pensieri che spesso vengono rivolti al padre della psicoanalisi e alla sua dottrina. Ma avendo ripercorso l’evoluzione del suo pensiero alla luce delle più recenti scoperte della psicologia dello sviluppo, della genetica, epigenetica e neuroscienze, si può ancora definirlo “superato”?
Bibliografia
Bjourklund, D. F., Causey, K. B. (2018) Children’s thinking. Cognitive developement and individual differences, Sage
Breuer, J., Freud, S., (1982) Comunicazione preliminare. Sul meccanismo psichico dei fenomeni isterici, in OSF
Freud, S. (1888), Isteria, in OSF
Freud, S. (1893), Minuta B, L’eredità e l’etiologia delle nevrosi, (Minute teoriche per Whilelm Fliess), in OSF
Freud, S. (1895) Studi sull’isteria, in OSF
Freud, S. (1895) Minuta K (Minute teoriche per Whilelm Fliess), in OSF
Innamorati, M., (2015) Freud, Roma, Carocci, (ed. digit.: 2021, doi: 10.978.8829/008650)
Mangia, F., Bevilacqua, A., Amicarelli, F., Chieffi, P., Fiorenza, M.T., Grilli, A (2018). Basi biologiche dell'attività psichica. Piccin, Padova.
Pick, D., (1999) Volti della degenerazione: una sindrome europea 1848-1918, trad. it. La Nuova Italia, Firenze
Teicher MH, Samson JA, Anderson CM, Ohashi K. The effects of childhood maltreatment on brain structure, function and connectivity. Nat Rev Neurosci. 2016 Sep 19;17(10):652-66. doi: 10.1038/nrn.2016.111. PMID: 27640984.

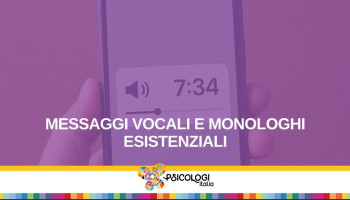




commenta questa pubblicazione
Sii il primo a commentare questo articolo...
Clicca qui per inserire un commento